Playlist per una fine del mondo millenial
24 febbraio – the End
La sera prima del primo giorno un manto di nubi sulle quali era stato ironicamente rovesciato un tramonto di fuoco e sangue dilagò tra gli schermi di tutta la provincia nel giro di una manciata di minuti.
L’Ordinanza era rimbalzata su quegli stessi schermi soltanto un’ora prima. le parole Sospensione, tutela, sanificazione, disinfezione messe in linea ordinatamente in un lungo messaggio che tanti di noi dovettero leggere più di una volta prima di capirne il significato. Quella parola soprattutto, Sospensione, era la più restia a farsi comprendere appieno. Per una settimana a partire dal giorno seguente, tutto ciò che non era ancora strettamente produttivo, e quindi necessario, arte, aggregazione, movimento, un generico “attività”, era da considerarsi sospeso per Ordinanza.
Davanti a quel cielo rosso in tanti afferrammo gli stessi schermi, bianchi fino a poco prima, e li tingemmo di quel rosso, immortalando e condividendo. Immortalando anche noi stessi su quello sfondo. Fermando sugli stessi schermi ciò che in quel momento era vicino, un bacio, un figlio, una famiglia, il tetto di casa nostra o un tetto qualsiasi, un albero cresciuto proprio lì nel corso di anni ed anni, il nostro luogo di lavoro o la strada su cui ci eravamo trovati ad essere in quel preciso momento di quella domenica di febbraio dell’anno 2020.
Come se quel rosso e quella parola, Sospensione, fossero già abbastanza per definire un presagio.
Le immagini che iniziarono a circolare il primo giorno erano immagini di scaffali vuoti nei supermercati, da diverse angolazioni e varianti a seconda della zona della città. Quella parola era arrivata a creare un vuoto, e noi avevamo iniziato a riempire quel vuoto nell’unico modo che ci era stato insegnato.
Comprando.
Era iniziata.
26 febbraio – It’s the end of the world as we know it
Uno dopo l’altro i giorni sulle nostre agende si fecero leggeri, pieni di cancellature e spazi vuoti dove prima erano impegni di vario genere.
Lezioni, prove, allenamenti, incontri, accordi. Nomi, cose, città. Come il gioco.
Cose e nomi a cui avevamo dato un preciso tempo, una priorità, rimandando il rimandabile e pianificando corse e pause; nomi a cui avevamo concesso un forse o un punto interrogativo, un “sentiamoci uno di questi giorni”, o un “appena mi libero”; o su cui avevamo puntato una certezza, come su una casella su cui speri di ripassare al prossimo giro.
Imprevisti e Opportunità di un mazzo che tutto sommato credevamo di conoscere.
Ora, tutto questo era stato ordinato come non essenziale, sospendibile. Qualcuno aveva cambiato mazzo e regole, lasciandoci come pedine su un’agenda sempre più vuota.
E più districavamo ora per necessità i nodi di quelle agende, e più ci rendevamo conto di quanto di noi fosse legato a quei nodi. Quanto ad essi ci fossimo da tempo inconsapevolmente aggrappati per non doverci fermare, o per non cadere, come naufraghi in mare aperto.
E quello che accadeva intorno a noi assumeva sempre più l’aspetto di un naufragio.
1 marzo – Rainmaker
E venne la pioggia.
Caddero cifre e dati, sottili come righe di pioggia. Migliaia di miliardi di perdite, diceva la Borsa. Gli analisti raccoglievano e facevano proiezioni. I commentatori si atteggiavano ad assumere il cipiglio bonario o corrucciato di chi tutto sommato può ricondurre la realtà a una riga di parole.
E migliaia di miliardi erano perduti, secondo la Borsa. Una realtà che difficilmente si incasellava ancora in righe di parole che avessero un senso.
Dopo giorni di nuvole cangianti, improvvise bufere, fioriture anomale, finiva la prima settimana di giorni sospesi, e con questa fine calava la pioggia. Ma non era una pioggia impetuosa, definitiva, provvidenziale.
Era la pioggia che meritavamo, sottile ed invisibile e scendeva per bagnare e basta.
Guardavamo la pioggia, ci asciugavamo per l’ennesima volta le mani, e ci ripetevamo mentalmente quelle cifre.
Migliaia di miliardi. Una vita umana non pareggia una cifra simile neppure in battiti di ciglia.
Migliaia di miliardi di valute fantasma. E tuttavia sparite. Da una parte all’altra di quel racconto collettivo che accettavamo: il racconto che tutto avesse un valore. A pensarci bene, questo sarebbe stato abbastanza per capire quanto irreale fosse quella realtà di parole e numeri messi in fila.
Ma anche questa scoperta sarebbe stata pur sempre solo un racconto.
Diversamente dall’acqua che cadeva. Fredda e sottile come paura.
4 marzo – Where is my mind?
Dopo più di una settimana non faceva più nemmeno ridere.
Gli scaffali nei supermercati erano, ovviamente, di nuovo pieni.
Sui nostri schermi continuavano a passare numeri e spiegazioni insieme a tutti i modi in cui ancora, tenacemente, eroicamente, si cercava di ridere di tutto ciò. Ma ormai anche la voglia di ridere, di esibire un cinico ghigno contro tutto questo, stava passando.
“A cosa stai pensando?”, ci chiedevano ancora quegli schermi, come se ancora potessimo credere che ciò a cui pensavamo fosse rilevante.
La vita che ci avevano insegnato era una scatola sigillata di aspettative e obblighi, relazioni da approvare, desideri da rendere accettabili, scale di misure a cui corrispondere. Ipocondrie di ogni tipo da mascherare. Ma ora questa cosa, che per sua natura andava oltre i soli fatti, ci stava iniziando a mostrare ognuna di quelle ipocondrie.
E più che spaventati eravamo arrabbiati.
E più sentivamo quella rabbia e più la riconoscevamo, perché non era la prima volta che la nostra generazione si sentiva dire che il futuro sarebbe stato duro, che le soluzioni avrebbero tardato ad arrivare, che le aspettative si sarebbero dovute rivedere, incasellare, rimandare.
Quella era la nostra Grande Guerra, una delle brevi, inconsistenti, surreali Grandi Guerre che vivevamo sui nostri schermi più che sulle nostre pelli. E la stavamo affrontando con il cinismo e la disillusione a cui anni di “È la crisi” e di “Andrà tutto bene” ci avevano addestrato.
La vita che ci avevano insegnato era una scatola, e ora questa scatola iniziava a crollare davanti a noi come i palazzi nell’ultima scena di Fight Club di Lynch. Diversamente da Edward Norton, però, non eravamo noi ad avere una pistola fumante in mano.
Avevamo schermi, che ancora una volta ci chiedevano:
“A cosa stai pensando?”
7 marzo – Too Many Friends
È quando il caffè ti viene servito con la mascherina e i guanti che inizi a realizzare che qualcosa sta accadendo.
Due settimane. Ciò che prima era sospeso, man mano stava diventando qualcos’altro. Rimandato a un futuro che dovevamo spostare sempre un po’ più in là. Oppure, più definitivamente, annullato.
Gli schermi, quella connessione non ancora intaccata da divieti, ospitavano i tentativi di mantenimento in vita della normalità, ma anche rabbia, paura, distorsioni, appelli, proteste. Chi diceva che andava tutto bene e chi diceva che andava tutto male. Chi cercava colpe ed errori. Perché era quella la normalità più dura a morire.
Ti veniva voglia di spegnerli sempre più spesso. Di uscire a chiedere “Come sta?” alla prima persona che incontravi, sorridere a chi incrociavi, osservare i luoghi pubblici ripopolarsi di bambini, giovani, famiglie che in un altro sabato pomeriggio sarebbero state altrove.
È quando un abbraccio diventa espressamente vietato che inizi a ragionare su che cosa sia un abbraccio. Su quanti ne hai sprecati, mantenuti troppo a lungo o troppo poco. Su quanti ne hai persi quando era il momento.
Perché un abbraccio è sempre una questione di coraggio.
E in mezzo a questi vuoti imposti c’eravamo noi. Che da sempre a sentir parlare di abbracci ci veniva da ridere.
Più i discorsi si facevano ripetitivi, ridondanti, incalzanti, e più dentro di noi urlava la voglia di silenzio.
Più i luoghi intorno a noi diventavano vuoti e meno ci sentivamo vuoti noi.
Perché col vuoto e col silenzio avevamo un conto aperto da prima che fossero imposti.
Perché quelli come noi la mancanza di paura l’avevano scambiata con un tipo diverso di fragilità.
Che fosse temporanea non aveva importanza: quella fine si stava scrivendo per noi.
E non ci sarebbe bastata.
15 marzo – Video games
E così da un momento all’altro un metro era tutto quello che avevamo per viverci dentro. Cento centimetri, la misura minima di quanto dovessimo stare lontani. Lo spazio per allungare le braccia.
Strani rivolgimenti accadevano ora dentro quel metro posto tra noi e il mondo. Scoprivamo che tante cose non erano vicine come avevamo voluto raccontarci. Abitudini, regole, persone. Che inaspettatamente, ora, lasciavano spazio a volti e ricordi che invece avevamo dati per persi e ormai lontani.
Usavamo il nostro metro per accendere l’ennesimo schermo e ci ritrovavamo da luoghi e tempi diversi, ma che scoprivamo appartenerci ancora. Ci ritrovavamo, ora, su fronti sparsi per il mondo. Di nuovo partecipanti a un gioco che conoscevamo bene.
Perché eravamo forse infantili, egoisti, duri, ma non ingenui: avevamo sempre saputo che la nostra vita non sarebbe stata un film, e così avevamo fatto della nostra vita un videogioco.
Un videogioco colorato e adrenalinico. Dove eri tu a scegliere che personaggio essere. In cui quando iniziavi a giocare, era per cambiare davvero le cose, ed eri pronto anche a rischiarle queste cose. Perché ci sarebbe stato sempre un ultimo salvataggio a cui tornare quando la situazione si sarebbe fatta troppo intricata.
In questo gioco, quando perdevi un cuore potevi andare avanti e ritrovarlo lungo la strada.
Ora la situazione era dannatamente intricata, e proprio come in un gioco, tornava a noi quello avevamo salvato.
Volti e ricordi tornati per riempire quel piccolo spazio.
Vicini da non aver bisogno di allungare le braccia per sfiorarli.
Un piccolo cuore in più. Era abbastanza, per andare avanti.
21 marzo – Numb
Che arroganti eravamo stati.
Convinti che ce ne saremmo andati solo portandoci dietro tutto quanto. Disastri atomici, esperimenti andati storti, le ultime sequoie schiantate al suolo. Sicuri che nulla avrebbe potuto essere lo stesso senza di noi.
Ora, al di fuori delle finestre dietro cui dovevamo confinarci, gli uccellini cantavano e gli alberi fiorivano. I satelliti fotografavano cieli che finalmente respiravano. C’eravamo creduti onnipotenti nei confronti del nostro pianeta e ora quel pianeta ci stava schiacciando come un brufolo. Come un parassita.
Da dietro quei vetri guardavamo fiorire una luminosa primavera e ascoltavamo le migliaia di canzoni accumulate negli anni, facendo scorrere le cose dietro i vetri come se fossero i finestrini dei nostri vecchi autobus.
I numeri sempre in crescita, tra cui avevano iniziato a comparire nomi a noi vicini. Appelli e minacce, prospettive di soldati in strada e di coprifuoco sempre più serrati.
Il ricordo delle primavere da piccoli. Quando le primule gialle si potevano mangiare, anche se non sapevano di nulla.
Gli adolescenti che eravamo stati, appoggiati nello stesso modo al finestrino con il cappuccio calato, le ginocchia sotto al mento e musica sparata nelle orecchie.
I primi lettori cd, così ingombranti da portarsi in giro con tutti quei dischi personalizzati e colorati. Quando ci facevamo urlare musica in testa per non urlare, per non chiederci troppo che sapore avesse un bacio, che sapore avesse un corpo. Che sapore avessero le lacrime degli altri.
Quello che come quei cd avevamo visto finire, passare di moda, venire rimpiazzato. Tagli di capelli, scarpe, prime ubriacature, modi di dire della durata di un’estate.
Avevamo amato cantanti che dopo averci insegnato l’amore e la ribellione si erano sparati, avevamo imitato lottatori poi trovati morti in camere d’albergo. Questo cosa ci diceva, ora, del nostro amore, della nostra ribellione, delle nostre lotte?
Difficile a volte non sentirsi poco più che parassiti.
Era il primo giorno di primavera e la primavera ci stava lasciando fuori.
Ancora dalla parte sbagliata di un vetro. A far scorrere tutto quello che stavamo perdendo insieme a tutto quello che non avevamo mai finito di perdere.
Con in bocca un sapore di lacrime che, ora lo sapevamo, era lo stesso per tutti.
Lo stesso sapore delle primule.
28 marzo – Paint it black
Guerra.
Una parola che aveva preso a risuonare sempre più nei nostri piccoli spazi, a dilatarli e oscurarli trasformandoli in campi minati e giungle in cui il nemico era sempre in agguato.
Che eravamo in guerra avevano iniziato a dirlo uno dopo l’altro presidenti, giornalisti, economisti, sindacati. Fino a che avevamo iniziato a ripeterlo pure noi, sottovoce, nel chiuso delle nostre pareti e dei nostri incubi.
Quella parola che prima si lasciava cadere per gioco adesso era suono di tamburi in marcia nei messaggi e nelle immagini che ci scorrevano davanti quotidianamente: bare in processione fuori dalle città, visi segnati dalle maschere, la rabbia sputata sullo schermo da chi non potendo vedere il nemico aveva fatto degli altri, di chi stava là fuori, il proprio nemico.
E poi c’era il fatto che uno di quei numeri che si aggiornavano ogni giorno stava diventando una lista di nomi. Ad alcuni di questi nomi avevamo un volto da associare.
E, beh, iniziava a fare male.
Raccattammo le nozioni belliche in nostro possesso.
Qualcosa su patriottismo e senso del dovere e del sacrificio. Qualcuno pronto a indicarti i responsabili di quella certa impressione che tutto stesse andando in malora. Spoiler alert: quel qualcuno stava regolarmente, sistematicamente, mentendo.
Il sergente Hartmann di Full Metal Jacket chiedeva ringhiando la nostra migliore faccia da guerra.
Ma per piacere. Non eravamo fatti per essere buoni soldati.
Avevamo appena finito di scavare la trincea che ci separava dai figli del boom economico, dai loro sprechi e dalle loro certezze che avevano finito col gettare noi in un fronte di compromessi, rimandi, fiato corto e dignità da difendere palmo a palmo.
Ed ora erano lì anche loro: reclute male armate in giungle di notizie false e dirottate pronte all’agguato. Resi pesanti e impacciati proprio da quella zavorra di certezze. Vergini all’idea che tutto quanto potesse spegnersi improvvisamente, come uno schermo a cui stacchi la spina per sbaglio.
Li guardavamo, ora, come non avevamo mai fatto. Con un affetto crudele da veterani.
Sarcastici e determinati. Marines tra le macerie in fiamme al ritmo della marcetta di Topolino.
Born to kill scritto sulle cuffie del pc.
4 aprile – Little by Little
Preriscaldare il forno a 220 gradi (200, se ventilato).
Un altro sabato sera da fine del mondo.
Togliere il prodotto dalla pellicola e metterlo in forno ancora congelato.
Un’altra serata a chiederci perché non avevamo mai davvero imparato a cucinare.
Aggiungere acqua bollente e aspettare.
Notiziari e governatori ripetevano ogni giorno che facevamo parte di una maledetta guerra e noi la stavamo passando a mescolare prodotti liofilizzati e ad alzare un angolo della pellicola prima di metterla in microonde.
A guardare vecchie serie tv e invidiare il fatto che quelli nello schermo potessero fare cose appetitose come aprire una porta e uscire, o incontrarsi in qualche posto di qualche città da qualche parte del mondo.
Quelle città erano state tutte nostre. Ogni posto, ogni esperienza, ogni emozione era stata alla nostra portata.
Avevamo scalato montagne e corso per le strade distruggendo macchine e motorini prima di attaccare un aspira polvere alla presa della corrente per la prima volta.
Avevamo imparato prima a mettere fine a un amore che a fare una lavatrice.
Stappavamo l’ennesima bottiglia in solitaria e riflettevamo su queste cose, mettendo in fila vecchie foto e ripromettendoci nuovi viaggi quando sarebbe finita. Ripromettendoci anche di imparare a cucinare e a dividere bianchi e colorati prima di un lavaggio.
Desideri da precuocere. Che sapore avrebbero avuto, dall’altra parte? Ci auguravamo qualcosa di diverso da quel retrogusto di cartone. Ci auguravamo solo di non ritrovarci surgelati, quando ne saremmo usciti.
Un altro piatto da lavare il giorno dopo. Altre confezioni da buttare. Un’altra puntata su cui premere “play”.
Avevamo corso e ci eravamo rotolati per i campi e ci eravamo gettati da aerei e ponti e fatto a botte e trattenuto il fiato sott’acqua e ci eravamo mandati al diavolo e persi e ritrovati e tutto questo senza mai guardare indietro, senza mai aver dovuto dare uno straccio di motivazione e giustificazione.
E adesso che una giustificazione la si doveva avere per tutto ci svegliavamo di notte e sentivamo il nostro cuore batterci contro le costole e temevamo di sparire, come le stelle che avevamo sempre desiderato diventare.
Splendide comete fatte per illuminare bruciando le notti. Incapaci di cercare giustificazioni e motivazioni quanto di mettere il giusto quantitativo di pasta nella pentola.
Un altro sabato sera di pandemia. A bere per due, per sentirsi in compagnia.
Lo schermo del telefono si oscurava dolcemente a indicarci l’ora.
Non avevamo mai pensato prima che uno schermo potesse fare qualcosa dolcemente.
12 aprile – We don’t celebrate Sundays
Non si riusciva a pensare ad altro che al dopo, ormai.
Era la Pasqua, con quel suo malcelato imbarazzo tipico delle feste. La malcelata necessità di un sacrificio. Non l’avevamo mai davvero capito quel bisogno di sacrificio, non ci eravamo fermati a cercare di capirlo. Qualcosa di arcaico e allo stesso tempo così contemporaneo.
Tutto quanto, dalla possibilità di scegliere il vestito migliore per la festa, la messa, la laurea, il colloquio; fino alla presenza del cibo sulla nostra tavola, e a quella infine dello schermo che ci permettesse di immortalare tutto questo. Il prezzo di tutto questo era da sempre il sacrificio di qualcun altro in qualche altra parte del pianeta.
Era la nostra antica religione, il nostro materialissimo patto di sangue. Il sacrificio di cui ci nutrivamo come dèi dall’alto di un altare: dimenticandoci però, che sull’altare vittime e dèi sono la stessa cosa.
D’altra parte, essere giudicati, dannati, salvati era stata una prospettiva da considerare unicamente come individui: il bene o il male verso gli altri non esistevano se non in relazione alle conseguenze che avrebbero avuto su di noi. Rendere conto di tutto alla fine, e sperare che dicesse bene.
C’era da sentirsi terribilmente soli, a pensarci.
Uno scambio. Questione di colpe, di costi e di sacrifici. E il grottesco era che nessuno ci aveva chiesto se fossimo d’accordo. Era veramente tutto qui?
Si ripeteva che tutto sarebbe stato fatto e speso per il dopo, intendendo così, che le cose dovessero tornare come prima. E non sapevamo, ormai, cosa ci piacesse meno tra quel “prima” e quell’idea di “dopo”.
Le feste mettono in imbarazzo perché spingono a pregare. O almeno a dubitare. E questa volta avevamo fin troppi motivi per dubitare, e tutti i motivi per pregare.
Pregare che stavolta il prezzo di quel “dopo” non fossimo noi, né nessun altro.
Non volevamo tornare indietro. Se era una colpa quella che si stava pagando, non rimaneva ora che la rinascita.
E con imbarazzo pregavamo che quella rinascita fosse, per una volta, condivisa.
18 aprile – Ordinary Life
Dove stavamo andando, prima?
Contro che cosa avremmo finito con lo schiantarci, se non fosse successo in questo modo?
Il tipo di domande che sorgono dopo aver capito che si possono passare ore intere stesi fissando un muro o uno schermo, con la sola differenza di un’illusione di movimento.
Poche, precise volte qualcosa era arrivato a picchiettare leggermente, come il corvo della poesia, dall’altra parte dello schermo dei nostri programmi per bambini. E magari era la Storia la s maiuscola, con le sue leggi e i suoi tempi che non appartengono a nessun altro ritmo, che veniva a interrompere le nostre fiabe quotidiane per raccontarci che lei era lì, da un’altra parte, ma c’era. Notizie da spegnere quando ci venivano a noia, e nulla più.
La nostra quotidianità di obiettivi a breve termine e aspirazioni da incorniciare sopra al letto si era fatta sempre più serrata e ordinata. Le fiabe avevano lasciato il posto al ritmo dei voti, delle agende, degli eventi. Tutto incasellabile nello spazio tra la sveglia al mattino e l’ultimo sguardo allo schermo prima di dormire.
Sempre accesi a quel ritmo di sonno e veglia, di obiettivi e caselle. E ogni tanto un vago, leggero “E’ tutto qui?” stretto come un alito di vento tra la gola e i denti. Piccoli fastidi da ingoiare, nulla più.
Il ritmo omogeneo di una quotidianità in cui tutto aveva comunque un suo posto, mentre il tempo scorreva ticchettando.
Leggeri ticchettii come di becco dall’altra parte del vetro. E forse era ancora quella cosa coi suoi volti senza futuro né aspirazioni che ritornava ogni tanto, per scorrere tra le altre cose sullo schermo. Ma non potevamo fermarci, perché in quello scorrere c’eravamo anche noi e per interromperlo ci sarebbe voluto uno schianto. Quindi le dedicavamo uno sguardo, un pensiero forse, nulla più.
Ora questo scorrere si era interrotto e noi rimanevamo fermi a fissare le nostre stanze, e a chiederci in quale misteriosa parte del tempo fossero andati a finire i nostri obiettivi. Guardavamo l’ora per accertarci che le giornate stessero continuando il loro corso, anche se il nostro ritmo non le muoveva più.
Domande troppo grandi. Risposte da cercare in fondo alla gola, proprio dove avevamo confinato tutti quei “E’ tutto qui?”. Quel che sapevamo era che quando tendevamo l’orecchio non c’era più nessun ticchettio.
Perché questa volta, quella cosa era entrata.
E come il corvo della poesia, portava con sé solo due parole.
Mai più.
29 aprile – Survive
L’ultima novità era che dovevamo iniziare a rendere conto dei nostri sentimenti.
Della stabilità dei nostri affetti.
Il nostro romanzo distopico su misura era iniziato con lo smantellamento di una quotidianità di impegni e distrazioni vissute come obblighi sociali, di ipocondrie e ansie con cui convivere sino a non vederle. Staccandocene a forza avevamo intravisto tutto questo: ma ora si richiedeva niente meno che essere pronti a schedare il proprio cuore per uscire.
E che cosa avremmo dovuto scriverci su quei fogli? Che il nostro cuore non l’avevamo mai conosciuto? Che stavamo uscendo per cercarlo un’altra, l’ennesima ultima volta?
Eravamo la cosa più lontana da quel concetto di stabilità. Isolati da sempre dietro muri che nemmeno potevano immaginare. Avremmo detto questo, a chi ci voleva controllare più di prima?
Non era solo il prima quello che avevamo intravisto in quei giorni, c’era qualcos’altro. Un’idea di futuro. Ancora confusa, ma c’era. L’idea di essere veramente partecipi di questo futuro allora così lontano, dall’altra parte di quei muri. Qualcosa che non si poteva schedare, mettere in linea con affetti, colpe, speranze, desideri, per una normalità che pure si era appena mostrata così fragile.
Lo sentivamo, era questione di giorni. Un progressivo ritorno si stava preparando. La questione ora era verso che cosa saremmo ritornati.
Li sentivamo già, perché non avevano mai smesso. Pronti a dirci con chi avremmo dovuto prendercela per l’ennesimo prezzo da pagare, ad usare la nostra rabbia e la nostra paura. A farci credere che la risposta che aspettava dietro i nostri muri fosse accettare muri ancora più grandi.
Pronti a prenderci anche quell’idea di futuro. Affinché non ne restasse il ricordo: una piccola deviazione di marcia, tutto qui. Pronti a dirci che, alla fine, era stata anche colpa nostra.
Ma il gioco ormai lo conoscevamo. E questa volta, avevamo iniziato a capire che cosa stessimo giocando.
Quello che segna la differenza tra una specie e un parassita.
3 maggio –Il mondo come lo vorrei
La sera dell’ultimo giorno i piumini della primavera danzavano trasportati dal vento di maggio nella luce di un tramonto dorato.
Sospesi nell’aria come sospesi erano stati quei sessantanove giorni. Come lo eravamo noi.
Sembrava dialogassero con le nuvole in una lingua silenziosa e sconosciuta, lanciando messaggi nella lontananza tra cielo e terra, tra frammenti e immensità. Come se stessero tracciando su quella luce la storia di tutti noi e di ogni altro giorno a venire, e quella storia avesse una sua perfetta armonia che soltanto noi non potevamo cogliere.
Dal giorno dopo, un piccolo passo per volta, la nostra storia sospesa avrebbe ripreso a scorrere.
Che cosa sarebbe effettivamente successo, non lo potevamo davvero immaginare. Come solo tre mesi prima non avremmo potuto immaginare quel che era accaduto fino ad allora.
Qualcuno, ovviamente, diceva che non sarebbe cambiato nulla. Ma anche il non darsi prospettive è un modo per cercare rassicurazioni. Ti libera dal peso di dover cambiare qualcosa.
La verità è che anche da quel momento poteva accadere qualsiasi cosa.
Avremmo potuto continuare a distruggerci a vicenda insieme a tutte le nostre sicurezze, cercando di vivere come sempre avevamo fatto ma con l’aggravante di non poterlo davvero più fare.
Oppure prendere quel poco di luce che, come mai prima, avevamo intravisto in tutto quel buio, e farne la nostra guida per avere una voce diversa su un futuro che non ci apparteneva, ma a cui saremmo immancabilmente appartenuti.
Quel tramonto ci riportava ai mondi che creavamo da piccoli, quando ogni gioco iniziava con un “Facciamo che” e non c’era bisogno di altro per sentirsi protagonisti di una bella storia.
E ci ricordava che a rendere possibili quelle storie eravamo sempre stati soltanto noi.
Quel che è successo dopo, è un’altra storia. Un giorno basterà guardarsi intorno, per saperla.
Questa finisce qui, in una sera di maggio.
Mentre ci affacciavamo dalla fine di tutto quanto.
E quello era soltanto l’inizio.
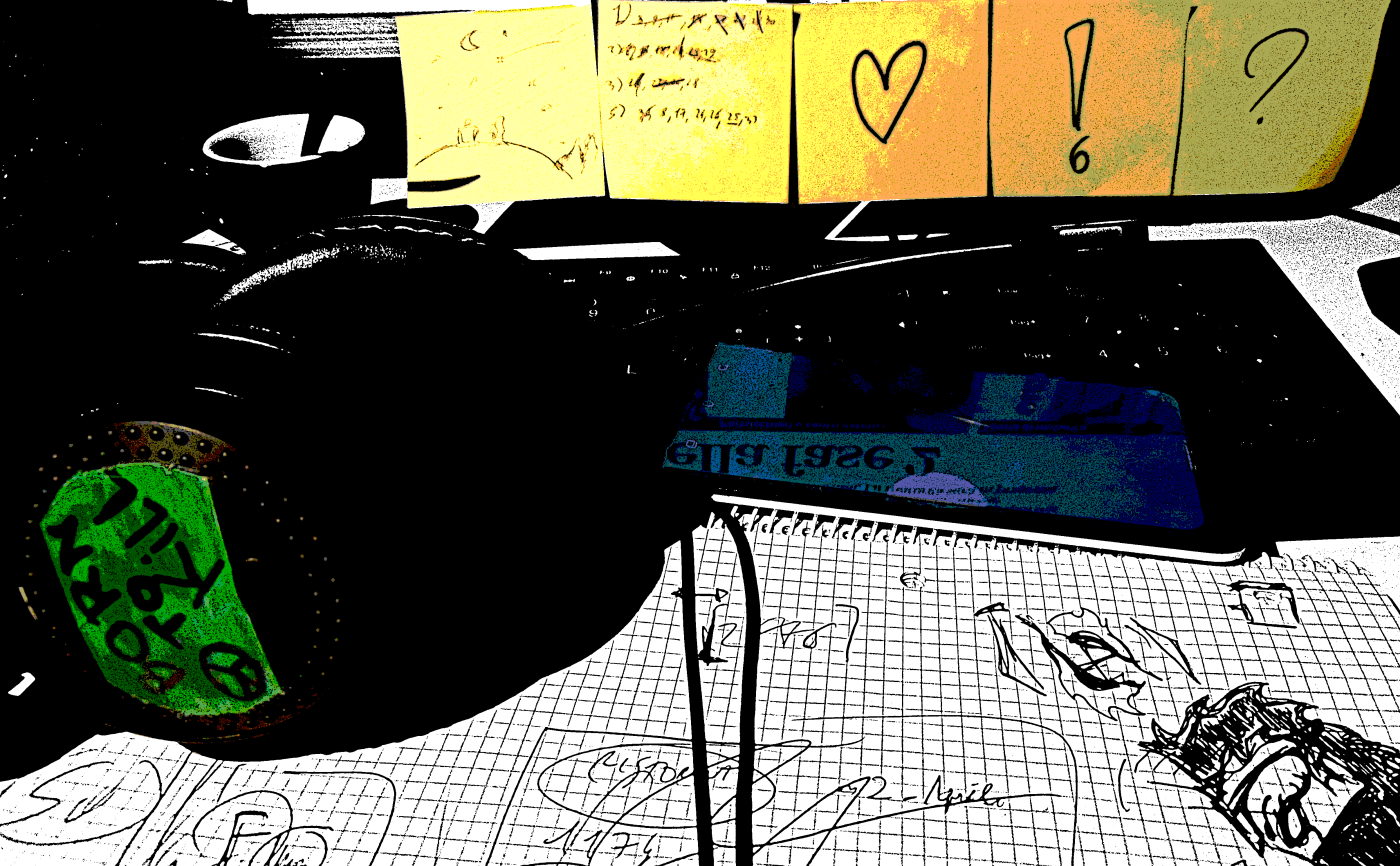



Lascia un commento